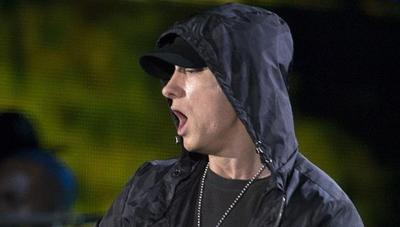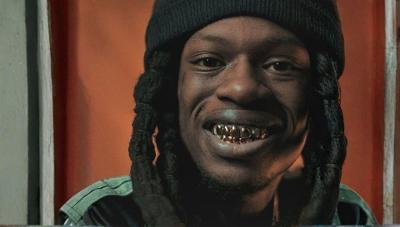Glossario per parlare e comprendere la violenza di genere
Il contrasto alla violenza di genere parte dal linguaggio, ecco un piccolo vocabolario per comprenderla

La prima forma di contrasto alla violenza è nominarla. Sembra una frase a effetto, ma nel linguaggio quotidiano, disponendo già di quasi tutti i vocaboli che servono per una comunicazione che varia dal base all’astratto, non ci si accorge della correlazione tra un problema e il dargli un nome appropriato. Le parole non sono soltanto un modo per dare nomi alla realtà ma un modo per distinguerne gli elementi tra di loro, perché in assenza dei termini penna e matita non si avrebbe cognizione di ciò che è chiamato penna e ciò che è chiamato matita.
A un bambino o una bambina cercherei di spiegare questo pilastro della linguistica e dunque della lotta alla violenza così: a scuola un compagno o una compagna vi rompono una penna per darvi fastidio. Vedere chi vi ha rotto la penna e questa rotta vi fa provare tristezza e magari un po’ di rabbia. Alla prima persona grande che incontrate, riportate l’accaduto ma non sapete più come si chiama la penna. Così provate a descrivere l’oggetto, dare dei dettagli ma a tratti tentennate perché siete tristi. L’adulta o l’adulto davanti a voi hanno bisogno di un po’ di tempo per, prima rincuorarvi, e poi capire l’accaduto, tanto che chi vi ha fatto il torto ha il tempo per pentirsene e voi decidete che non ne vale più la pena. Avere consapevolezza terminologica delle dinamiche di violenza è una necessità quantomai fondamentale per riconoscerla, comprenderla, analizzarla e contrastarla, soprattutto in tempistiche rispettose. Gli studi postcoloniali, il frutto “positivo” di millenni di violenze politiche, sono l’esempio eloquente di quanto, per reagire a un atteggiamento oppressivo, non bastino carte firmate e terre riconsegnate, ma un lavoro continuo e profondo per costruire nuove lingue, culture e menti ripulite dall’impregnatura violenta che le infesta.
Ngugi wa Thiong’o pubblica nel 1986, Decolonizing the mind o Decolonizzare la mente, testo nel quale mette in luce che l’influenza corrosiva dell’inglese non permette una pulizia rigenerativa delle culture e società da decolonizzare. Il problema chiave è uno: quanto ha senso parlare della decolonizzazione nella lingua del colonizzatore? E quindi, quanto ha senso parlare di violenze in una lingua imperniata di legittimazioni di violenze?
Identificare la violenza di e del genere: di cosa si tratta?
Le violenze di e del genere sono un insieme di violenze fisiche, verbali, simboliche e psicologiche di cui sono vittime le donne, le persone omosessuali e bisessuali, le persone trans* e non-binary a causa delle logiche patriarcali e eterocisnormative della società. Questa assegna loro un minore valore, potere, privilegi, diritti e risorse. Non esiste un’unica categoria di violenze, manifestandosi sotto forme diverse che le caricano di differenti sfumature di leggibilità. Esistono forme più visibili e riconoscibili, pur essendo spesso normalizzate, altre meno evidenti, le cui spalle sono coperte da una cultura che le dà per assodate e ne riproduce e fomenta le radici dell’oppressione.
Le violenze maschili contro le donne, le violenze omolesbobitransfobiche e le violenze imposte dal binarismo di genere hanno radici comuni e con conseguenze intersezionali, riguardando anche differenze etniche, socio-economiche, di età e abilità. Detto in altri termini la cultura che legittima la violenza domestica di un marito nei confronti della moglie, la vessazione di un adolescente omosessuale da parte di un gruppo di pari o l’appellare una donna trans con pronomi maschili affondano le radici nei medesimi stereotipi di genere e nei medesimi rapporti di potere. Non è quindi possibile comprenderne una senza il riconoscimento di tutte le altre, nella consapevolezza che ognuna agisce con specificità e con regimi di visibilità differenti.
Affermazione di genere: riguarda il percorso attraverso il quale alcune persone trans*, non tutte, decidono di intervenire sul proprio corpo al fine di portarlo alla forma che piu si addice a come si sentono. L’iter prevede varie fasi: psicologiche, mediche e legali e può comprendere un trattamento ormonale e/o interventi chirurgici. L’espressione si presentava precedentemente come transizione, oggi si preferisce questa perché permette di concentrarsi non sul passaggio fisico da uno stato a quello considerato opposto, ma sulle concrete possibilità che ogni persona trans* ha per esprimere chi sente di essere.
Bullismo omolesbobitransfobico: violenza tra pari perpetrata all’interno di un contesto di comitiva. Lo caratterizzano tre fattori: l’asimmetria tra chi agisce bullizzando e chi lo subisce, l’intenzionalità di chi perpetra l’atto per creare un danno alla vittima, e la sua ripetitività, le prevaricazioni si presentano in maniera continua. Le vessazioni e le violenze rilevate riguardano il reale o presunto orientamento sessuale e/o identità di genere della vittima. Se accade in contesti digitali, in quel caso si parla di cyberbullismo a sfondo omolesbotransfobico.
Catcalling: molestia di origine maschile, di natura verbale e/o gestuale, di matrice sessuale rivolta con o meno tono minaccioso nei confronti di una donna per strada o in un contesto pubblico in quanto donna.
Centro antiviolenza (CAV): si tratta di luoghi gestite da donne che prestano aiuto ad altre donne, che siano sole o con minori, senza distinzioni di cittadinanza, etnia e orientamento sessuale, che vivono o hanno subito una situazione di violenza. Il lavoro del CAV si basa sulla relazione tra donne, che gratuitamente e nel rispetto dell’anonimato e della riservatezza, operano con attività di accoglienza, ascolto (telefonico anche e h24), consulenza legale, psicologica e sociale, orientamento al lavoro, accompagnamento nei percorsi di autonomia delle donne. Recentemente se ne occupano anche persone non cisgender, per fornire una rete di riferimento e aiuto a chiunque si trovi in una situazione di violenza. Ogni Regione ha un CAV di appartenenza. Per conoscerlo, si contatta il numero nazionale antiviolenza e antistalking 1522, che indicherà subito il più vicino.
Cisgender: identità di genere in cui sesso e genere assegnati alla nascita coincidono e non sono fonte di disagio; viene abbreviato in cis. Le persone dichiaratesi cisgender non si troveranno a fare coming out rispetto a tale caratteristica, e questa è una forma di privilegio.
Cisnormatività: si tratta di una gerarchia sistemica che privilegia le persone cisgender. In questo quadro di potere i generi riconosciuti sono solo due, il maschile e il femminile, e si sostiene che sesso e genere coincidano. Le persone cisgender risultano così normali, mentre le persone trans* e non binarie, considerate non normali, subiscono stigmatizzazione. La dicitura si trova spesso anche come ciseteronormatività o eterocisnormatività, essendo le norme di genere spesso intrecciate a quelle sulla sessualità.
Coming out: momento in cui una persona omosessuale, non binary o trans* decide di raccontare la propria identità a una o più persone. Il momento non è unico, può avvenire in modi diversi e ripetersi, in contesti e momenti differenti.
Cultura patriarcale: denominazione oggi discussa per l’accezione storica di patriarcale, linguisticamente connesso a pater, di cui pater familias di ascendenza latina. L’inserimento nel glossario è una scelta personale, dovuta al fatto che riconosco la dinamica sociale e culturale basata sul privilegio maschile, cis, bianco e abile nella forma di violenza, discriminazione, invisibilizzazione e marginalizzazione delle altre parti sociali nel mondo antico come nel contemporaneo. Il sistema vorrebbe avvalorare una società in cui il potere è detenuto da uomini cisgender. Le modalità attraverso cui si perpetra la cultura patriarcale sono molteplici: dalla violenza, al linguaggio, alla strutturazione di rapporti sociali di potere e alla possibilità o meno di accedere a diritti, riconoscimenti e risorse. Non è detto che le dinamiche di oppressione siano evidenti, e sono inevitabilmente connesse a una cultura cisnormativa.
Cultura dello stupro: impostazione culturale e socialmente condivisa, in base alla quale la violenza è percepita come desiderabile e la sessualità come violenta. L’uomo viene concepito come predatore e la donna come preda sessuale. Non riguarda soltanto l’atto in sé, quanto si tratta di un insieme di usi quotidiani assoggettatori: lessico misogino, oggettivazione dei corpi femminili, processi- anche altamente mediatici- di spettacolarizzazione della violenza maschile contro le donne.
Deadnaming: scelta personale e irrispettosa di chiamare una persona trans* o non binaria con il nome anagrafico, e non con il nome da lei scelto, senza il suo consenso.
LGBTQ+: acronimo con cui si identificano le plurali possibilità di vivere e identificare la propria sessualità e/o la propria identità di genere, nell’ordine esso raggruppa chi si riconosce come Lesbica Gay Bisessuale Transgender Queer Intersex. Il segno “+” indica che le possibilità di genere e sessualità sono molte di più di quanto un singolo acronimo possa dire. Chi vive una o più di queste identificazioni può subire oppressioni e violenze sia a livello personale che sistemico e istituzionale. L’acronimo si trova anche in altre forme, come LGBT, LGBT+ o LGBTQIPA+.
Eterosessismo: concezione del mondo per cui è naturale e legittima la sola eterosessualità, per cui si assumi che chiunque sia eterosessuale. Che sia come atteggiamento individuale o sociale, l’eterosessismo si traduce nel rifiuto, nella denigrazione e stigmatizzazione di ogni forma di comportamento, identità e relazione non dichiaratamente eterosessuale. Questo si cela dietro l’omolesbobitransfobia.
Eteronormatività: sinonimo di eterosessismo che pone l’accento sulla dimensione normativa e prescrittiva della visione eterosessista. È la somma di pratiche e istituzioni che legittimano e privilegiano l’eterosessualità caratterizzata da monogamia, convivenza tesa al matrimonio, riproduzione come finalità del legame, struttura famigliare nucleare e coincidenza totale tra genere e sesso.
Intersezionalità: termine usato per indicare i modi in cui le dinamiche di disuguaglianza basate su genere, razza, etnia, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, classe o altre caratteristiche identitarie si intersecano tra loro producendo forme specifiche di discriminazione e violenza, non altrimenti contrastate, se considerate una alla volta.
Misgendering: uso attraverso cui non viene rispettato il genere di una persona, tramite pronomi, aggettivi, sostantivi e participi passati declinati sulla base del sesso/genere assegnato alla nascita.
Mispronouming: specificazione del misgendering, per cui si ignorano volontariamente i pronomi di una persona trans* o non binaria, utilizzando, al contrario, quelli coerenti con il sesso/genere assegnato alla nascita.
Non-binary (o persone non binarie): chi non si riconosce e assegna un’identità cisgender, e quindi non sente che sesso e genere assegnati alla nascita coincidono. Può al contempo non identificarsi come trans*. Pensato e usato come termine ombrello, accoglie al proprio interno diverse esperienze e identità di genere, in questo possono rientrare: persone agender, coloro che non sentono di appartenere ad alcun genere; bigender, chi si identifica con entrambi i generi di femminile e maschile; genderfluid, coloro che non considerano il genere come fisso e immutabile, per cui la consapevolezza di genere fluisce tra i generi.
Omolesbobitransfobia: insieme di atteggiamenti nocivi nei confronti di donne lesbiche, uomini gay e di persone bisessuali, trans e queer che si manifesta in discriminazioni fisiche, verbali, psicologiche e istituzionali.
Outing: svelare, a singole persone o in contesti pubblici, l’identità di genere e/o l’orientamento sessuale di una persona senza il suo consenso. Azione contraria al coming out, per cui irrispettosa e non eticamente corretta.
Queer: termine ombrello che si riferisce a coloro il cui orientamento sessuale e/o identità di genere differisce da eterosessualità e/o da un’identità cisgender. Usato per allargare l’acronimo LGBT+. Il termine queer vuole dare l’idea di un’infinita possibilità di identità e orientamenti in continua evoluzione.
Sesso assegnato alla nascita: o “sesso biologico”, si riferisce alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e genetiche associate al sesso maschile o femminile: cromosomi sessuali, caratteri sessuali primari (genitali esterni, gonadi), caratteri sessuali secondari (peli, seno, timbro della voce, tessuto adiposo, etc.), assetto ormonale. Il sesso biologico viene automaticamente assegnato e stabilito dalle persone adulte prima della nascita.
Trans*: termine assomma quelle persone la cui identità e/o espressione di genere differisce da sesso e genere assegnati loro alla nascita. Qui rientrano soggettività trans-binarie, per le quali la non coincidenza tra sesso assegnato alla nascita e genere percepito è unita al desiderio di appartenere al genere considerato opposto, e trans non binarie, per le quali l’identità di genere non corrisponde al binomio opposto maschile-femminile. Vivere un’esperienza trans* non significa accedere a un percorso di affermazione di genere.
Transfobia: qualsiasi atteggiamento di odio, disprezzo, disapprovazione, violenza rivolto alle persone trans* e non binarie in quanto trans* e non binarie. Le sue forme sono varie:aggressioni fisiche e psicologiche, molestie sessuali, delegittimazioni verbali, insulti, misgendering, deadnaming, mispronouming.
Violenza assistita: quando una persona di età non adulta assiste o percepisce forme di maltrattamento compiuti attraverso atti di violenza fisica, psicologica, verbale, economica, sessuale agite su figure di riferimento, prevalentemente verso la madre o su altre persone a cui sono affettivamente legati.
Violenza maschile contro le donne: maltrattamenti di violenza fisica, psicologica, verbale, economica, sessuale, come le minacce di compiere tali atti, la coercizione e la privazione arbitraria della libertà, nella vita pubblica e nella vita privata, messe in atto da uomini contro le donne, in quanto donne.
Violenza patriarcale: qualsiasi forma di violenza perpetrata in modo sistematico contro soggettività socialmente marginalizzate: donne, persone LGBTQ+ in nome della sovrastruttura fondata sul privilegio maschile, bianco, cisgender, abile con il solo scopo di discriminare, subordinare le soggettività con violenza fisica, verbale, economica, psicologica e sessuale. La cultura dello stupro, la limitazione di accesso a diritti e risorse, l’inivisibilizzazione di persone non eterosessuali e non cisgender, rappresentano altrettante forme in cui la violenza patriarcale si manifesta nella società.
Questo un glossario agevole e tascabile per essere soggetti attivi oggi: riconoscere, nominare e denunciare con il nome che le persone, come anche le violenze, si meritano.