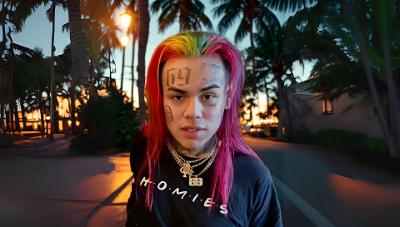Socialmente Bello. Lo sport non cambia il mondo da solo, ma può essere lo strumento per costruire comunità
Intervista a Paolo Arioti, maestro di pugilato e vicepresidente della Palestra Popolare San Lorenzo

Nel cuore di uno dei quartieri più vitali e contraddittori di Roma, da oltre 25 anni esiste una palestra diversa da tutte le altre: la Palestra Popolare San Lorenzo. Nata nel 1998 da un’occupazione di spazi abbandonati, oggi è un punto di riferimento per lo sport, l’inclusione e la partecipazione attiva. Un luogo in cui si praticano il pugilato, il karate e molte altre discipline, a prezzi popolari, ma soprattutto si coltivano relazioni e si costruisce comunità. Abbiamo intervistato Paolo Arioti, 51 anni, romano, maestro di pugilato e vicepresidente dell’associazione sportiva, per farci raccontare la storia e i valori di questa realtà che ha fatto dello sport un motore di cambiamento sociale.
Paolo, ci racconti cos’è la Palestra Popolare di San Lorenzo e come nasce questa esperienza?
La Palpop è uno spazio sottratto all’abbandono e rigenerato attraverso lo sport. Nasce alla fine degli anni ’90, in un periodo in cui a Roma si apriva il dibattito sulla destinazione d’uso del patrimonio pubblico. Il 22 giugno 1998, un gruppo di compagne e compagni provenienti dai centri sociali e dalle occupazioni abitative — in particolare da Onda Rossa, in via dei Volsci — occupa i locali abbandonati al civico 94 della stessa via. L’obiettivo era chiaro: dare vita a esperienze che parlassero di qualità della vita, non solo come risposta a bisogni o consumi, ma come spazio per coltivare passioni, desideri e relazioni. Da lì è cominciata la nostra avventura. A Roma, la nostra è stata la prima palestra popolare, il primo spazio sociale dedicato interamente allo sport.
Ma cosa intendiamo davvero quando parliamo di “sport popolare”?
Non è facile darne una definizione univoca, perché si tratta di una pratica che è sempre esistita, spesso ai margini, nei cortili, nei parchi, nelle palestre di quartiere. Lo sport, per sua natura, ha bisogno di numeri ampi: si rivolge a una fetta larga della popolazione, parla a tante persone, attraversa generazioni e contesti. Ma troppo spesso è stato ridotto a consumo individuale, a prestazione, a prodotto. La nostra idea, invece, nasce da un’altra visione, che è quella di sottrarre spazi all’abbandono, all’incuria, alla speculazione, e restituirli alla collettività attraverso lo sport. Farne luoghi vivi, accessibili, aperti. Il termine “popolare” lo prendiamo in prestito dall’urbanistica: come le case popolari, anche lo sport è un diritto, un’attività di cura e benessere che dovrebbe essere garantito in ogni quartiere, accanto a spazi culturali, sociali, educativi. Immaginiamo una città in cui ogni territorio abbia le sue “case e palestre popolari”, dove tutte e tutti possano allenarsi, incontrarsi, crescere, indipendentemente dalle possibilità economiche, dall’età, dalle abilità o dalla provenienza. È questa l’idea che ci guida: costruire comunità attraverso lo sport, a partire dai bisogni reali delle persone.
Quali attività proponete oggi? E a chi vi rivolgete principalmente?
In 27 anni di attività abbiamo visto evolversi molto il nostro lavoro, ma una cosa è rimasta al centro: l’idea che una comunità è fatta da tutte e tutti, con le proprie specificità, storie, provenienze, abilità e appartenenze. Per questo ci rivolgiamo alla comunità nella sua interezza, senza frammentarla o selezionarla. Lo sport, nella sua forma più autentica, deve essere accessibile e significativo per ognuno, ed è proprio in questa direzione che abbiamo sviluppato il nostro percorso sullo sport integrato. Lavorare insieme a persone con disabilità, soprattutto attraverso il para-karate anche a livello agonistico, non è stata una scelta “in più”, ma un passaggio che ci ha resi più completi come insegnanti, come atleti e come comunità. Ha migliorato le prestazioni di tutti, ma soprattutto ha cambiato la prospettiva: ci ha aiutato a superare quella vecchia logica che divide lo sport “dei normodotati” da quello “per disabili”, come se fossero mondi separati. Invece siamo parte di un’unica comunità e dobbiamo agire come tale: riconoscerci nei corpi e nei vissuti degli altri, includere tutte le soggettività, praticare insieme. Solo così si costruisce qualcosa di davvero condiviso e trasformativo.
In che modo lo sport può diventare uno strumento di inclusione, riscatto e crescita per i giovani?
Lo sport, da solo, non risolve le situazioni. È l’uso che se ne fa a fare la differenza. Per noi è fondamentale riempirlo di contenuti sociali, valorizzare le persone prima delle prestazioni. Il nostro settore amatoriale, ad esempio, finanzia l’attività agonistica. Ma l’agonismo restituisce a sua volta qualcosa: sperimentazioni, pratiche, metodologie che migliorano il rapporto col corpo e con lo spazio. Se lo sport diventa uno strumento per costruire benessere collettivo, allora ha senso.
Avete storie di ragazze e ragazzi che, grazie alla palestra, hanno trovato un nuovo senso di appartenenza o hanno cambiato strada?
Tantissime. Ma abbiamo imparato che noi possiamo solo aprire porte: sta alle persone scegliere se attraversarle. Abbiamo visto percorsi di riscatto, trasformazioni personali profonde. Lo sport fa bene a tutte le persone, ma forse ancor di più a chi non è "il più bravo". Ti dà un metodo, ti insegna a raggiungere i tuoi obiettivi, a ricalibrarti. E ti offre l’opportunità di esplorare nuove strade, sportive o professionali. Ma devi sempre affiancarlo ad altro, alla studio, alla formazione: se non diventa una fonte di reddito, servono altre opportunità per costruire il proprio futuro.
La vostra non è solo una palestra: è anche un luogo di relazione e partecipazione. Come si costruisce una comunità in uno spazio sportivo?
La Palpop è nata da un’occupazione e da una lunga, tenace vertenza per l’assegnazione di uno spazio pubblico abbandonato. Non ci è stato regalato nulla: ci siamo presi la responsabilità di restituire vita e senso a un luogo dimenticato, lo abbiamo ristrutturato a nostre spese, con il nostro lavoro. Lo abbiamo reso uno spazio attrezzato per l’attività sportiva e per farlo abbiamo messo in campo ogni forma possibile di partecipazione e resistenza. Ci siamo autofinanziati con concerti, feste, dibattiti, attività sportive; lo abbiamo difeso e preservato con manifestazioni, volantinaggi, raccolte fondi e campagne pubbliche. Abbiamo trasformato ogni iniziativa in un’occasione per affermare il diritto di tutte e tutti a uno spazio comune, accessibile, partecipato. Questo percorso non ha solo garantito la sopravvivenza della palestra: ha costruito la sua identità profonda, fatta di cura, lotta, mutualismo e appartenenza. Oggi chiunque può frequentare la Palpop, iscriversi ai corsi, allenarsi, partecipare. Ma il cuore pulsante resta quella comunità attiva che l’ha fondata e difesa e chi, ogni giorno anche se arrivato dopo, si impegna per farla crescere. Persone che non hanno mai pensato allo sport come a un servizio da acquistare, ma come a uno strumento collettivo per costruire relazioni, solidarietà e consapevolezza. Siamo quindi uno spazio aperto a chiunque abbia voglia di far parte di questa storia collettiva, sempre in crescita, sempre in movimento.
Qual è l’atmosfera che si respira entrando da voi? Cosa vi differenzia da una palestra “tradizionale”?
Intanto, qui si fa sport, non fitness. È una differenza sostanziale. Lo sport ha una sua concezione: include bambini, adulti, agonisti, amatori. Il fitness, invece, è spesso legato al concetto di cliente e si rivolge a una fascia ristretta, dai 20 ai 60 anni circa. Noi proponiamo un’altra idea di sport: un’esperienza collettiva, che significa tutto quello di cui abbiamo parlato fino ad ora, non un servizio da vendere.
Che ruolo hanno i giovani nella vita quotidiana della palestra?
La Palpop non è solo una palestra: è uno spazio sociale, politico e relazionale nato da un’occupazione e da una lunga vertenza durata oltre 15 anni con il Comune di Roma. Una battaglia complessa, faticosa, ma profondamente formativa, che ha generato molto più di un risultato amministrativo: ha costruito identità, senso di appartenenza e affezione profonda al concetto di bene collettivo. Difendere quello spazio — con azioni concrete, con l’autofinanziamento, con feste, concerti, dibattiti, sport — ha significato dare un contenuto vivo e comune a quell’idea spesso astratta di “patrimonio pubblico”. Abbiamo imparato e trasmesso che ciò che è pubblico non è di nessuno, ma è di tutte e tutti: qualcosa da prendersi cura insieme, da rendere accessibile, da vivere quotidianamente e, se necessario, da difendere. Quell’esperienza ci ha insegnato che la partecipazione non si dichiara, si pratica, e che costruire una comunità intorno a un bene pubblico — uno spazio rigenerato e condiviso — è già, di per sé, un atto politico. Oggi, chi entra alla Palpop percepisce subito che non si trova in un luogo qualunque: ma in un luogo vissuto, difeso, costruito con passione e fatica, e per questo sentito come proprio da chi lo anima ogni giorno
Quanto è importante per voi il legame con il quartiere?
L’identità territoriale, per noi, è un valore, non una chiusura. Se tante ASD portano nel nome il proprio quartiere non è un caso: è un segno di radicamento, di appartenenza, di legame reale con un territorio e con le persone che lo vivono. Il rapporto con chi abita qui è forte, quotidiano, positivo. Non ci riconosciamo in un nazionalismo identitario, che esclude e divide; ci riconosciamo invece nella dignità delle persone e nella capacità collettiva di far valere i propri diritti. Il nome del quartiere è un punto di riferimento, certo, ma il vero collante è fatto di valori comuni, non di confini geografici. Io e Jeff Bezos potremmo anche essere nati nella stessa strada, ma questo non significa che abbiamo qualcosa in comune. Quello che ci unisce è un’idea condivisa di giustizia, solidarietà, cura. San Lorenzo non è solo il luogo in cui ci troviamo, è la comunità che abbiamo scelto di costruire ogni giorno, insieme.
Che messaggio volete trasmettere con il vostro lavoro quotidiano?
È possibile coniugare passione, valori e impegno lavorativo, costruendo spazi che rispondano ai bisogni della comunità e riflettano ciò in cui crediamo. Non è semplice, ma si può fare. E quando ci si riesce, anche solo in parte, la soddisfazione è tanta, perché il proprio impegno acquista senso dentro una visione collettiva.
Cosa diresti a una persona giovane che vuole impegnarsi nel sociale ma non sa da dove cominciare?
"Ma chi te lo fa fare?". Scherzi a parte, credo che, se non ti batti per qualcosa in cui credi, difficilmente lo vedrai realizzarsi. C’è troppa retorica da "vecchi ai tempi loro", una sfiducia generazionale insopportabile. Io non voglio fare la morale, ma solo testimoniare che mi sono battuto per tutta la vita per quello in cui credo, e posso dire di aver vissuto una appagante. Se ci credi, comincia. Il resto viene.