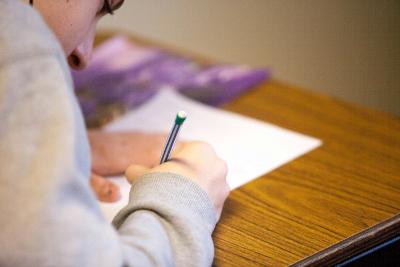Indipendenza giovanile: dal desiderio di essere a quello di avere
La battaglia per l’indipendenza dei ragazzi è un filo rosso che collega tutte le generazioni. Come è cambiata nel tempo? Cosa volevano i nostri nonni e cosa vogliono i giovani di oggi?

Per anni abbiamo pensato all’indipendenza giovanile come un pacchetto che ci viene consegnato al conseguire della maggiore età, che troviamo nella cassetta della posta una mattina di un giorno qualsiasi e che ci dà la possibilità di decidere del nostro futuro e del nostro denaro. Lo stereotipo dell'adolescente di oggi che sogna un futuro da decidere tutto da sé lo abbiamo ben presente nella nostra testa: aria infastidita perché sarebbe voluto rimanere a saltare su una musica strappa orecchie fino alle 6 del mattino ma è dovuto rincasare a mezzanotte con l'ultimo passaggio. C'è poi la sorella ordinata che si trova a condividere la stanza con l'incarnazione del caos, o ancora il figlio indispettito da un genitore troppo opprimente e che non ha mai imparato a bussare alla porta prima di entrare. Tutti quanti hanno in comune la voglia sfrenata di avere un posto tutto per sé, che si tratti di una macchina, di una camera da non condividere con nessuno o di una casa intera: un luogo dove liberarsi dagli sguardi e dai giudizi altrui. Buona parte dei ragazzi concorda con questa visione spaziale dell'indipendenza, d'altronde l'indipendenza mentale nasce spesso da quella fisica: dove c'è lo spazio per il corpo di muoversi senza barriere c'è anche quello della mente per viaggiare senza limiti. È una storia antica, il corpo influenza la mente e la mente, il più delle volte, si esprime attraverso il nostro corpo quando gli impediamo di dar voce ai pensieri. A molti ragazzi basta, e non in senso semplicistico, una stanza dove attaccare i poster dei film più visti e le foto con gli amici; ottenere la "proprietà" di un pezzetto di muro può significare molto quando ci sembra che nulla ci appartiene e tutto ci va stretto. Sembra però che la caratteristica tanto speciale di quello spazio non sia la pacifica solitudine che troviamo al suo interno, ma la possibilità di vincolare la presenza esterna al nostro consenso, come se quell'ambiente fosse un prolungamento di noi stessi. Indipendenza diventa quindi possedere qualcosa che è solo nostro e che come tale ci dà il diritto di porre paletti e regole per il suo godimento.
Emerging adulthood
In una società sempre più vicina all’ideale consumista in cui tutto è materiale e reale solo se pubblico, persino le emozioni, la concezione di un’indipendenza prima di tutto fisica e solo dopo mentale rischia di appiattirsi a una delle tante cose da dimostrare al pubblico e da spuntare sulla lista per diventare adulti. Lì, dopo la laurea e prima della convivenza, del matrimonio e dei figli c’è quella casellina da annerire intitolata “comprare una casa o una macchina per sentirmi autonomo”, come se la volontà di decidere per se stessi più che la possibilità autentica di autodeterminarsi diventasse una tappa obbligatoria imposta da aspettative sociali e culturali. Lo psicologo dello sviluppo Jeffrey Jensen Arnett descrive il concetto con la frase “emerging adulthood”, ovvero quella sensazione che provano i ragazzi nei loro 20 anni di trovarsi esattamente in mezzo a due fasi ma di non appartenere a nessuna delle due, la percezione di non essere ancora pienamente adulti ma di doverlo essere; ed è qui che entrano in gioco le pressioni sociali: per diventare grandi bisogna ottenere lo status symbol della stabilità e della realizzazione: l’indipendenza, che si tratti di soldi o di una proprietà non conta. Ma è davvero tale se imposta dalla volontà di conformarsi? C’è poi una grande criticità che i giovani di oggi si trovano ad affrontare: se da un lato crescono le aspettative nei loro confronti, dall’altro lato le reali possibilità di attenderle vengono ostacolate dalle condizioni economiche e burocratiche sempre più difficili, rendendo l’intero processo una corsa a ostacoli in cui la società ci mette in competizione con chi ha raggiunto l’autonomia negli anni del boom economico. In ogni caso non è sempre stato così, i nonni e le generazioni passate se lo ricordano bene, e forse è proprio alle loro lotte che dovremmo rivolgere lo sguardo per uscire dal loop descritto da Arnett.
L'indipendenza dei nostri nonni
Non era poi così strano per i nostri nonni lavorare a quella che oggi è ancora l’età per la scuola dell'obbligo, sposarsi negli anni dell'adolescenza e lasciare casa per diventare madri e padri quando anche essi non erano altro che figli da crescere. Inevitabilmente guadagnare dei soldi, anche se pochi, non equivaleva a guadagnarsi anche l’autonomia, soprattutto se questi finivano nel fondo familiare per la spesa. A cavallo tra le due guerre, per le donne, neanche lasciare la famiglia d’origine, sposarsi in adolescenza e dare alla luce un figlio appena sedicenni significava indipendenza; quel rito infatti voleva dire sostanzialmente una cosa: passare da un capo famiglia a un altro. Non tutte le storie erano le stesse, l’amore vero esisteva anche in tempi di guerra, ma il diritto di stampo fortemente patriarcale e violento nei confronti delle donne -pensate al delitto d’onore, il divieto di voto e il diritto del marito di “correggere” la moglie- dipinge una società ben precisa. La prima ventata d’aria la portano la suffragette, quando parliamo delle battaglie delle donne in quegli anni dobbiamo ricordarci che non si tratta di una lotta circoscritta al diritto di voto e l’emancipazione femminile, ma di una vera e propria rivoluzione il cui fulcro è proprio l’indipendenza, specialmente se si parla di giovani donne. Poi dal periodo d'ombra degli anni '40 e sulla scia del secondo dopoguerra è nata la Costituzione che rivendica la libertà positiva dei cittadini, anche i più piccoli, di vedersi tutelati e protetti dalla Repubblica; così arrivano le prime norme sul lavoro minorile e il diritto allo studio gratuito, ma anche il dovere dei genitori di istruire ed educare i propri figli e la protezione all'infanzia. I giovani degli anni '50 iniziano ad assaporare l'indipendenza che almeno in teoria la legge finalmente garantisce: in questo caso più la libertà di essere semplicemente giovani senza pretese di assomigliare nel ruolo e nei compiti a un adulto, che la libertà che immaginiamo oggi, ma pur sempre un passo avanti. La vera svolta arriva al tramonto degli anni '60 con i moti del 1968: i ragazzi riempiono le piazze, giovani operai e universitari l'uno a fianco all'altro uniti in un unico grido per un'istruzione democratica non solo sulla carta ma anche nelle aule, per la promozione di un'uguaglianza che non faccia distinzioni di genere, regione e reddito; per un governo rivolto alla pace e la cessazione di quella tradizione autoritaria che ancora viveva nelle istituzioni più alte ma anche in famiglia e negli uffici di università e scuole. Si chiede che il primato di una Costituzione tanto perfetta e inclusiva trovi fondamento nella realtà, e nel tempo ci si è avvicinati e allontanati spesso dal compimento di questo obiettivo (certo senza dimenticare la violenza sfrenata con cui all'occorrenza si è represso questo movimento di cui i giovani sono storicamente i portabandiera). La definizione di "emancipazione giovanile", introdotta prima dal Codice Civile del '42 e messa a punto dopo i moti del '68 con le riforme degli anni ‘70, raggiunge la vetta più alta di questa battaglia: ora sposarsi in giovane età vuol dire emanciparsi e non più sottomettersi a un sistema patriarcale che vedeva le donne madri e mogli sin dalla nascita; sebbene la sostanza sembri la stessa la differenza essenziale sta in quell'elemento che prima di allora sembrava sconosciuto: la volontà, nonché la libertà di decidersi.
Poi negli anni è come se l’indipendenza tanto desiderata e combattuta si fosse progressivamente svuotata: se prima si sognava la “libertà di essere” ora sogniamo la “libertà di avere”. È curioso osservare questo concetto in relazione a un fenomeno che governa la quotidianità: la sovranità dell’autodeterminazione nella sua forma più commerciale ed egoistica che ci spinge a pensare che il libero arbitrio ci dia la possibilità di comportarci come gli ultimi esseri viventi sulla Terra. Possiamo comprare tutto se ne abbiamo la possibilità, alla faccia della sostenibilità ambientale, dello sfruttamento, dei salari a zero dall'altra parte del mondo; possiamo esprimere la nostra opinione perché la "libertà di pensiero è sacrosanta", non importa se lede i diritti altrui, se specula su argomenti su cui non abbiamo la minima conoscenza, se mostra una visione della realtà distorta, se alimenta il fuoco delle fake news e genera schiere di odiatori seriali da tastiera. Se i nostri nonni non avevano la possibilità di scegliere la maggior parte degli aspetti della loro vita quotidiana, dalle frivolezze alle scelte di vita, noi siamo la versione più decisionista che il mondo abbia mai conosciuto.
Eppure c’è ancora qualcuno che conserva quell’antica scintilla dei giovani del ‘68. I ragazzi sono stanchi di sentirsi costretti a seguire le tappe di un percorso su cui non hanno voce in capitolo. Allora le piazze si riempiono di nuovo, oggi come decenni fa alla ricerca di indipendenza. Se un secolo fa gli adolescenti sognavano una libertà senza imposizioni oggi la sognano senza aspettative; entrambi però una cosa in comune ce l’hanno: il desiderio di poter scrivere da sé la propria storia.