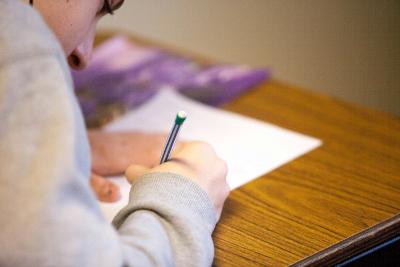“La notte degli uomini” di Parigi non è un evento isolato, ma ben radicato nella società
Nella notte tra il 21 e il 22 giugno 145 persone, tra le quali più di 100 donne hanno denunciato di essere state punte per strada

È la sera tra il 21 giugno e il 22 giugno e tutta Parigi balla: al Palais Royal c’è del folk francese, al cortile dell’Eliseo qualche nota jazz, a Notre Dame de l’Arche d’Alliance si salta sulla techno e la città festeggia l’arrivo del solstizio d’estate. Nella stessa notte 145 persone vengono punte per strada.
Le testimonianze sono tutte simili: segni di puntura su gambe, braccia, collo o la sensazione di un ago che punge all’improvviso,così malori di vario genere quali vertigini e nausea. Gli arrestati sono una quindicina di uomini di età compresa tra i 19 e i 44 anni ma come riporta un agente di polizia sulla TF1: “alcuni hanno ammesso i fatti, senza riuscire a spiegare perché lo hanno fatto”. Le ipotesi presentate sono diverse: esperti del fenomeno suggeriscono la dinamica della “sottomissione chimica”, ovvero drogare una persona per abusarne senza che questa possa reagire; altri, siringhe piene della “droga dello stupro”, le sostanze psicoattive come il GBL o GHB con gli effetti sedativi, usati per violenze sessuali ai danni di persone incoscienti o quasi. C’è chi parla di un’altra possibile sostanza iniettata, l’insulina o l’adrenalina, già naturalmente prodotte dal corpo e così difficilmente rilevabili dalle analisi. La supposizione più accreditata è che le punture non siano state causate da siringhe ma da aghi o semplici stuzzicadenti, il cui unico obiettivo è creare uno stato di panico generale e instillare nelle donne il terrore dello spazio pubblico.
Una storia già nota
Il Paese ha già vissuto il fenomeno delle “punture di strada”: uno degli ultimi casi risale al 2022, quando circa 2000 persone si ritrovarono a denunciare la sensazione di iniezioni improvvise e continue, senza però riscontrare alcuna sostanza nel corpo delle vittime a seguito di analisi tossicologiche. Nessun arresto fu registrato. Un testo chiave per l’analisi del fenomeno è “La notte degli uomini: un’inchiesta sulla sottomissione chimica”, pubblicato dal giornalista francese ed ex dottorando in sociologia delle droghe Félix Lemaître nel 2024.
La GHD, le punture selvagge e i sonniferi hanno una lunga storia: l’opinione pubblica e i media davanti agli stupri e le violenze sessuali partono a caccia di mostri ma Lemaître si interroga su chi e perché vuole terrorizzare le donne. L’indagine pone l’accento sulla destrutturazione del mito che ha sempre protetto gli aggressori: l’idea che esista una droga dello stupro usata dagli stupratori, ovvero il mezzo è soggetto e l’uomo oggetto, e non dei violentatori che con mezzi vari violentano, dunque uomini soggetto e le aggressioni oggetto. Lo svisceramento del cuore della mascolinità è evidenziato fin dal titolo: “la notte degli uomini”. Un tempo fisso e formulare nei racconti delle violenze, che è monopolio del solo genere maschile, come suggerisce l’aggettivo possessivo, usato per ricordare alla società che il corpo femminile è inanimato e va sfruttato come modus identificandis per il genere opposto.
1819, Parigi. 400 donne denunciano una violenza mai registrata prima: iniezioni inflitte da sconosciuti nei teatri, nei mercati, in luoghi pubblici affollati con aghi, punteruoli o bastoni muniti di pungiglioni. Gli attacchi si diffondono anche in altre città fino a varcare i limiti nazionali e diventare un fenomeno conosciuto anche all’estero. La cronaca individua una nuova categoria criminale, i “piqeurs” o pungiglioni, presentati come uomini perversi affetti da devianze sessuali, definiti anche come mostri o vampiri invisibili.
La città si tramuta subito in uno spazio di violenza e qualsiasi uomo in un potenziale aggressore: il panico divampa per le strade e le accuse, spesso infondate, proliferano. Stando ai resoconti della polizia dell’epoca, la ferita tipica giungeva fino in profondità e provocava un sanguinamento, o meglio, questo era l’intento. Le vittime giovani donne che, nella maggioranza dei casi, non avevano subito la sola puntura ma questa perveniva a seguito di palpeggiamenti. Le vittime prescelte presentano tutte lo stesso profilo: giovani donne che per l’educazione ricevuta, la timidezza insegnata e imposta e il timore di causare scandalo non si sentono libere di denunciare le offese subite.
Il panico e l’analisi del fenomeno sono subito travisate in chiave politica, in nome di teorie complottiste come una nuova manifestazione giacobina contro i fedeli al re. La maschilista manipolazione della taratura degli avvenimenti condanna le vere vittime, le donne, a una non curanza generale. Le vittime cominciano a restare a casa e a uscire solo se accompagnate.
Lemaître lega esplicitamente la violenza di massa nello spazio pubblico a una misoginia sempre più strutturata e che è la risposta alla nuova affermazione femminile negli spazi pubblici. La moda ottocentesca suggerisce le stesse dinamiche: il bustino. La fascia toracica non serve per segnare le forme ma per limitare la respirazione, così la libertà di movimento e di occupazione dello spazio. Le donne che indossano i pantaloni riempiono un posto e non usano solo il loro, valicano i confini di quello degli altri, nel significato per cui si muovono e vivono. La gonna è l’abito della timidezza, dell’eleganza principesca, dello stare all’angolo che sono tutti sinonimi di un meccanismo di controllo esistenziale.
Il terrore di vivere lo spazio pubblico
La filosofa femminista Alessandra Chiricotta, nel suo decennale impegno nella riflessione filosofica sullo spazio delle donne, ha presentato una nuova interpretazione dell’agorafobia femminile. Da fuori a dentro, dalla vita vissuta nello spazio pubblico alla casa, alle donne viene ora imposto di recludersi e concepirsi solo in un luogo limitato e controllato. Quando si trovano a uscire di nuovo, vivono uno sbandamento davanti agli stimoli esterni, alla percezione di non avere un limite nel muoversi e ciò provoca in loro la sensazione di non essere in grado di gestire il proprio corpo fuori casa e l’atteggiamento autoindotto di preclusione.
Come fa notare Lemaître, la dinamica odierna è la stessa: far capire alle donne che i luoghi pubblici non sono un luogo dove possono essere spensierate. A detta del ministero dell’Interno francese, gli attacchi sono stati spesso alimentati da sfide sui social network, circolate nelle ore precedenti alla festa della musica, riprese da femministe che hanno allora avvertito la categoria fragile.
Spaventare le donne negli spazi pubblici, di sera, di notte, con sconosciuti che cercano di aggredirle è una realtà. Quest’ultima si carica di grande risonanza in occasione di determinate circostante, quali ad esempio aggressioni con aghi. La paura delle siringhe rientra in una dinamica sensazionalista, nata dall’immaginario violento e turpe legato a chi ne fa uso; una costruzione simbolica ma ad hoc contro categorie sociali prestabilite: tossicodipendenti e sieropositivi. Non di meno l’accaduto spinge a constatare la giusta e stanca agitazione sociale circa l’accaduto, sebbene non ancora corale. L’instillazione di un generale e generico terrore nel vivere lo spazio pubblico, ovvero la quotidianità, dunque esistere, è quanto di più subdolo, pauroso e preoccupante una società possa partorire.
La storia suggerisce i passaggi delle violenze contro l’altro: costruzione di un mito, individuazione di una colpa, attentati di bassa taratura, esclusione dalla vita ordinaria, preclusione ed eliminazione. E sebbene a livello collettivo sia faticoso riconoscerlo, contro le donne, contro quello che ancora si ritiene essere “il secondo sesso” viene perpetrata la medesima dinamica.
Ogni forma di violenza è prima di tutto una forma di prevaricazione dello spazio altrui: spazio che non è solo fisico ma sociale, lavorativo, linguistico e intellettuale. Minando la sicurezza fisica, l’uomo logora la certezza delle donne di esistere in uno spazio proprio, di averne il possesso, il controllo e così la libertà. Come ogni forma di preclusione dimostra, la perdita della percezione spaziale induce a incapacità relazionale, di senso di sé e così alla sottomissione totale.
Il messaggio è questo “le donne non devono sentirsi libere negli spazi pubblici” e la ragione una sola, essere donne.